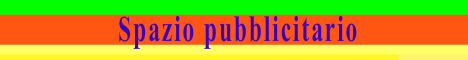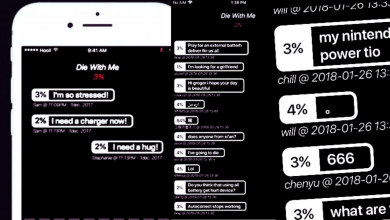Tesla lancia Optimus Gen 2: la prossima generazione di robot umanoidi

Contenuti
Tesla ha presentato Optimus Gen 2, una nuova versione del suo robot umanoide che potrebbe sostituire l’uomo in compiti ripetitivi. Optimus, conosciuto anche come Tesla Bot, non è stato preso sul serio da molti al di fuori dei fan più appassionati di Tesla, e ci sono delle ragioni valide per questo.
Quando è stato annunciato per la prima volta, sembrava un’idea incompleta da parte del CEO Elon Musk, con una ballerina travestita da robot come aiuto visivo.
La dimostrazione al Tesla AI Day dell’anno scorso non ha aiutato a migliorare la situazione, siccome non è stata affatto impressionante.
In quel momento, Tesla aveva un prototipo molto rudimentale che non sembrava molto promettente. Era appena in grado di camminare e salutare la folla. Questo è tutto.
Tuttavia, abbiamo notato che l’idea alla base del progetto era ragionevole. È ben noto il valore di un robot umanoide in grado di sostituire il lavoro umano a basso costo, ma molti dubitano che ciò possa essere realizzato nel breve termine.
Tesla crede che sia possibile realizzare questo obiettivo sfruttando il proprio lavoro sull’intelligenza artificiale per i veicoli a guida autonoma, nonché le proprie competenze in batterie e motori elettrici.
L’azienda americana sostiene anche che i propri veicoli sono già dei robot su ruote. Ora devono solo trasformarli in forma umanoide per poter sostituire gli esseri umani in determinati compiti.
Abbiamo notato che il progetto ha guadagnato credibilità con l’aggiornamento presentato durante l’assemblea degli azionisti di Tesla nel 2023 all’inizio di quest’anno. Durante quell’occasione, Tesla ha mostrato diversi nuovi prototipi che sembravano più avanzati e in grado di svolgere compiti effettivamente utili.
Aggiornamento sul robot umanoide Optimus di Tesla
In quell’occasione, Tesla ha annunciato che Optimus è stato addestrato con reti neurali end-to-end ed è stato in grado di eseguire nuovi compiti, come il sorting degli oggetti in modo autonomo.
Tesla presenta Optimus Gen 2: il suo nuovo robot umanoide. Il robot umanoide di Tesla ha una manualità invidiabile.
Oggi Tesla ha rilasciato un nuovo aggiornamento sul programma Optimus. Questa volta l’azienda automobilistica ha presentato Optimus Gen 2, una nuova generazione del prototipo di robot umanoide: Questa versione del robot ora ha tutti gli attuatori e i sensori progettati da Tesla. Inoltre, sembra molto più raffinato in generale.
Con questa nuova versione, Tesla afferma che il robot è in grado di camminare il 30% più velocemente. L’azienda ha anche dichiarato di aver ridotto il peso di 10 kg, migliorando l’equilibrio.
Una delle parti più complesse nella realizzazione di un robot umanoide utile sono le mani. Devono essere abbastanza forti da sostenere pesi significativi e allo stesso tempo sufficientemente precise per maneggiare oggetti delicati.
Tesla Optimus Gen 2 presenta nuove mani che sembrano un importante aggiornamento.
Tesla presenta Optimus Gen 2: il suo nuovo robot umanoide . Nuove capacità delle mani di Optimus G2 | fonte Tesla, elettronauti. L’azienda ha dichiarato di voler iniziare presto a utilizzare il robot nelle proprie operazioni di produzione. Una volta dimostrata la sua utilità, Tesla prevede di iniziare a vendere il robot.