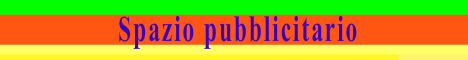Politica
1 settimana fa
ROBERTO SANTANGELO: “INACCETTABILI LE DICHIARAZIONI DEL GENERALE VANNACCI”
“Ritengo inaccettabili le dichiarazioni del generale Roberto Vannacci in merito alla separazione delle classi per…
Cultura
3 settimane fa
“Un’altra Africa è possibile”
Muore Andrea Botta, il missionario laico che credeva nello sviluppo economico indipendente del continente africanoAchille…
Health
3 settimane fa
Farmacie Comunali dell’Aquila pronte alla sfida della “Farmacia dei servizi”.
Potranno estendersi tutte le vaccinazioni alla popolazione con età superiore a 12 anniSarà possibile effettuare…
Politica
3 settimane fa
La destra snobba confronto e avalla decreto “spaccaItalia”.
La destra evita il confronto nella massima assise cittadinaCon questa norma della destra si vuole…
Cronaca
3 settimane fa
Inconfondibile boato attira l’attenzione: missione degli aerei tricolori
Cos’è stato quel inconfondibile boato?L’MB.339 può essere utilizzato anche per missioni di supporto aereo ravvicinato…
Cronaca
4 settimane fa
Tappa a Tione degli Abruzzi per “La corriera dei nonni lettori”
Tappa a Tione degli Abruzzi (L’Aquila) per “La Corriera dei nonni lettori” Si spera vivamente nella…
Politica
4 settimane fa
Autonomia, Centrosinistra, Fermare legge “spaccaItalia”.
Al consiglio sono stati invitati consiglieri regionali e parlamentari Diciamo No a questa legge della…
Cronaca
4 settimane fa
De Blasis:”Mantenere una forte industria farmaceutica in Abruzzo e in Europa”
Il rischio? Che le industrie scelgano altri paesiL’importanza della industria e di una politica industriale…
Politica
4 settimane fa
Consiglio Regionale d’Abruzzo: Santangelo onorato di servire la regione
Così Roberto Santangelo, neo Assessore al Welfare e al Sociale della Regione Abruzzo: Le Politiche…
Cronaca
Aprile 5, 2024
Simon Zhu a L’Aquila domenica 7 aprile in concerto
Finale vinta da Simon Zhu Simon Zhu, titolare di borse di studio in Liechtenstein in…